 Un dialogo a tuttocampo sull’attività di uno studioso-architetto che merita di essere conosciuto meglio anche per la sua produzione creativa.
Un dialogo a tuttocampo sull’attività di uno studioso-architetto che merita di essere conosciuto meglio anche per la sua produzione creativa.
E’ fra gli storici dell’architettura più conosciuti, ma è anche l’autore di numerosi progetti architettonici che uniscono i valori della tradizione a contenuti che continuano a sorprendere per la loro attualità, alimentando il dibattito professionale. Proprio sull’attività di progettista, sinergica al suo lavoro di storico, punta l’attenzione questa intervista concessa in esclusiva a Tracce
Ciò che accomuna i tanti progetti di Portoghesi è il desiderio di mettere insieme elementi diversi, a volte perfino contraddittori, di contaminare, di unire il vecchio e il nuovo, in un’interpretazione dell’architettura che coinvolge la memoria collettiva e personale. Questa intervista concessa in esclusiva a Tracce, ci permette di riconsiderare sotto una nuova luce questi concetti.
“E’ sotto gli occhi di tutti: l’architettura in Italia è entrata in una fase di visibilità mediatica ben più ampia di quella riservata agli addetti ai lavori. Negli anni Cinquanta e Sessanta l’Italia era fra i Paesi nei quali si parlava di più di architettura. Poi c’è stato un lungo periodo di silenzio. Da qualche anno si è riportata al centro dell’attenzione l’architettura, però su un piano completamente diverso. Si è venuto a creare il fenomeno dei cosiddetti “archistar”, personalità certamente affascinanti ma che concentrano su di loro l’intera attenzione sul senso e la propositività dell’architettura contemporanea. Professionisti che assumono anche gran parte del lavoro più vistoso, quelle che vengono chiamate “le grandi commesse”.
Parallelamente si è affermato un altro fenomeno, che è tutto interno alla cultura architettonica: il conflitto generazionale. Una nuova generazione tende ad emergere, ed in parte vi riesce, basandosi sul principio che per affermarsi vi è la necessità di contrapporsi a quella precedente. Questo però, a mio giudizio, sta nascondendo le dinamiche più valide dell’architettura moderna: le tendenze, che continuano altresì ad esistere. Fino al razionalismo le posizioni erano chiare: nessun architetto tendeva ad affermare se stesso, ma affermare delle idee. Il problema è che oggi l’architettura viene spesso ridotta ad arte puramente figurativa. Dico riduzione perché è vero che l’architettura è anche un’arte figurativa, ma resta qualcosa di molto più ampio. Secondo il mio giudizio sarebbe importante restituire all’architettura moderna il suo impulso originario, un imperativo sostanzialmente etico”.
La rivalutazione delle potenzialità dei materiali: cemento e legno fra razionalità e creatività
Non Le sembra che la scelta e l’utilizzo dei materiali costruttivi sia un altro aspetto che andrebbe riconsiderato alla luce di quanto fino ad ora Lei ha ricordato?
“Certamente. Pensiamo ad esempio al calcestruzzo armato. Alle opportunità che esso offre ben oltre quanto comunemente si pensi. A distanza di quasi un secolo dalla sua diffusione, questo metodo costruttivo dimostra ancora una vivacità propositiva sorprendente. Ritengo che al cemento vada riconosciuta la capacità di risolvere egregiamente molti compiti, ben oltre la razionalità al quale comunemente esso è associato.
Vorrei anche ricordare che la scelta e l’uso dei materiali sono da ricondurre al fatto che l’architettura è un vero e proprio linguaggio, che ha proprio nei materiali il suo principale repertorio espressivo. Un linguaggio che, come tutti i linguaggi, si fonda sulla volontà di comunicare.
Un grande merito dell’architettura moderna è stato quello di riconoscere la costruttività come linguaggio. Per questo sottolineo sempre l’importanza di quanto ci ha lasciato la cultura del barocco. La tradizione barocca rappresenta infatti la prefigurazione dell’architettura come lingua. Attualmente sono molto interessato a quei tentativi che si stanno facendo in America e in Giappone di recuperare pienamente la forza della comunicazione architettonica. Il lavoro di un architetto come Toyo Ito, ad esempio, lo reputo molto interessante. Altrettanto ed in modo convergente mi interessa il rapporto con la natura. La natura offre infatti strutture e processi, in particolare quello della crescita, che sono perfettamente assimilabili nella composizione architettonica. Oggi effettivamente vi è un grande interesse verso l’utilizzazione degli insegnamenti della natura, sia in modo un pò strumentale come fa la bionica, che cerca di dedurre dalla natura delle strutture applicabili alla scienza delle costruzioni, sia in senso più ampio ispirandosi all’ambiente naturale come contraltare all’artificializzazione estrema della città. Sempre per quanto riguarda il rapporto fra architettura e linguaggi materici, mi affascina continuare a riflettere sulle potenzialità del legno. Il legno è un materiale che comunica per sua natura, ponendo in primo piano un senso di calore partecipativo determinato dal suo essere sempre e comunque materiale vivo, anche quando è utilizzato nelle costruzioni.”
Il recupero ambientale nella prassi progettuale
“Il mio interesse per la natura è di lunga data: vedo oggi pienamente realizzate alcune intuizioni da me elaborate oltre trenta anni orsono. Su questo tema sarebbe però auspicabile una maggiore collaborazione fra architetti e team di lavoro costituiti da professionisti specializzati in altri settori, come la psicologia ad esempio.
Un territorio di ricerca che penso possa dare risultati inaspettati. Così come mettere in rapporto le conquiste della scienza con l’attività dell’architetto. Pensiamo anche ai musei: a volte assistiamo a contenitori che non tengono pienamente conto del contenuto o dei fruitori dell’edificio.
Lo stesso fenomeno lo vediamo nei luoghi di culto, anche se esistono esperienze di alto valore. La qualità e le possibilità di ricerca non sono però dipendenti esclusivamente dal tipo di commessa. Personalmente ho lavorato recentemente nel campo dell’edilizia residenziale, che costituisce l’elemento base del tessuto urbano. Disegnare o ridisegnare l’ambiente residenziale può contribuire in misura determinante all’idea e al progetto di città. Vivere quotidianamente dentro un progetto coerente a determinati valori è certamente un buon modo per passare dall’idea di un’architettura come pura teoria a un’architettura come parte integrante e qualificante dell’esistenza”.
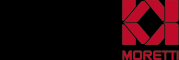
![Ospedale S. Luca, Milano “La costruzione del nuovo Ospedale S. Luca di Milano ci […]](https://tracce.morettispa.it/wp-content/uploads/2013/03/Ospedale-S.Luca-115-100x115.jpg)
![Nox Hotel, Ljubljana, Slovenia Il Nox Hotel, progetto di architettura di Niki Motoh – […]](https://tracce.morettispa.it/wp-content/uploads/2013/12/Nox-Hotel-Ljubljana-cover-100x110.jpg)
![Edilizia abitativa: percorso più semplice per il FIA Dal 2013 cambia il parametro limite di partecipazione per il […]](https://tracce.morettispa.it/wp-content/uploads/2013/12/FIA-cover-100x110.jpg)
![Rafiq Azam Architecture for Green Living Rafiq Azam Architecture for Green Living è la prima monografia […]](https://tracce.morettispa.it/wp-content/uploads/2013/11/RAFIQ-AZAM-cover-100x120.jpg)