 Gabriele Buratti è architetto e professore di architettura degli interni alla Facoltà del Design del Politecnico di Milano. La redazione di Tracce lo ha incontrato nel suo studio “Buratti+Battiston Architects”, di cui è partner con il fratello Oscar, anche lui architetto.
Gabriele Buratti è architetto e professore di architettura degli interni alla Facoltà del Design del Politecnico di Milano. La redazione di Tracce lo ha incontrato nel suo studio “Buratti+Battiston Architects”, di cui è partner con il fratello Oscar, anche lui architetto.
Diverse sono le scale d’intervento dei progetti sviluppati dallo studio: edifici residenziali, commerciali, industriali ed interventi in centri storici; curano l’immagine delle boutiques La Perla realizzando negozi nelle più importanti città del mondo; sono protagonisti indiscussi del design made in Italy realizzando mobili ed oggetti per B&B Italia, Antonio Lupi, Acerbis, Roca, iGuzzini e molti altri importanti brands.

 L’architettura contemporanea non può non tener conto della “contemporaneità”.
L’architettura contemporanea non può non tener conto della “contemporaneità”.
A Gabriele Buratti abbiamo chiesto in che modo l’attuale momento di instabilità contagia
il mondo della progettazione.
In un momento come quello attuale, certamente di crisi ma anche di riflessione, la questione della qualità ne può uscire rinnovata. Ciò è sostanzialmente legato a logiche di mercato: quando l’aspetto della vendita diventa critico ed il mercato seleziona di più, è essenziale lavorare sulla qualità, nel senso più ampio del termine.
Per noi architetti si tratta di qualità progettuale, dell’architettura e del paesaggio, dello spazio interno e dell’ambiente esterno, degli arredi e degli oggetti che usiamo quotidianamente e che arredano le nostre case ed i luoghi dove lavoriamo.
Qualità nel senso di progetti corretti e adeguati, per prestazioni, durata, costi, ma anche e soprattutto dal punto di vista della bellezza e della capacità di qualificare, appunto, l’ambiente in cui viviamo, domestico e privato, urbano e pubblico.


 Il progetto dunque come punto d’equilibrio. Nella tua professione ti occupi di progetti architettonici, di interni, di allestimenti e retail, fino al prodotto. E’ un vantaggio o solo confusione.
Il progetto dunque come punto d’equilibrio. Nella tua professione ti occupi di progetti architettonici, di interni, di allestimenti e retail, fino al prodotto. E’ un vantaggio o solo confusione.
Per fare un buon progetto bisogna avere una buona idea. Per noi progetto vuol dire appunto disegnare un’idea. Se l’idea è chiara e forte è il suo contenuto che può reggere e risolvere tutte le complessità che il progetto stesso incontrerà.
Per quanto riguarda l’aspetto di lavorare in maniera trasversale ed a scale diverse, questa è una modalità tipicamente italiana del fare architettura, propria della nostra cultura progettuale, diversamente da come avviene all’estero, dove vince la specializzazione.
Spesso parliamo di Franco Albini e di Giò Ponti…. , ci pacerebbe riuscire a controllare la scala del progetto come loro sono riusciti a fare, progettando sedie, interni, allestimenti ed edifici esemplari.
Il nostro lavoro sul design è molto legato a quello sull’architettura e viceversa, ci interessa lavorare a scale diverse, con la consapevolezza che la qualità del progetto sta proprio nella capacità di controllarne la scala, la sua dimensione e le sue proporzioni, per non fare una torre come una penna o una casa come un’automobile; per quanto ci riguarda, questo approccio ci ha consentito di crescere dal punto di vista della qualità del nostro lavoro.
Anche il tema della precisione e della cura del dettaglio è per noi molto importante.
Precisione del concetto e dell’idea, precisione nel disegno e nelle proporzioni, precisione nella definizione dei dettagli e nella costruzione.
“Dio sta nei dettagli” diceva Mies van der Rohe.
Non ci interessa il dettaglio in sé, ma la sua capacità di rappresentare e di dare significato e valore al tutto, di trasformare un punto notevole, spesso critico e vulnerabile, in qualità complessiva del prodotto o dell’edificio.
Nel nostro lavoro la definizione del dettaglio è un’operazione estremamente lunga, complessa e faticosa, che alla fine sfocia quasi sempre in una soluzione “naturale” e “normale”, come se non potesse essere che così. Nel dettaglio vi è la raffinatezza, il carattere e la qualità dell’intero progetto.
La parola “sostenibile” cosa ti fa venire in mente riferito alla progettazione.
Penso che ci sono parole che entrano con tale forza nel comune lessico e vengono usate con tale frequenza da provocare dibattiti accesi, prima ancora di essere comprese.
La parola sostenibilità è una di queste, un termine molto di moda che a fatica si traduce in soluzioni concrete. Dal mio punto di vista ci sono due possibili interpretazioni: una più tecnica, nel senso che ci sono delle questioni che devono far parte del progetto quasi a prescindere; tra queste sicuramente il risparmio energetico e la scelta di materiali adeguati per consumare meno. L’altra, più generica e più aperta, è quella che riguarda la sostenibilità del fare architettura e progetto, del quando e come costruire, la sostenibilità nel senso della qualità dell’intervento architettonico e delle sue performances, urbane, spaziali, domestiche, più in generale di qualità della vita.
La funzione della costruzione è un elemento sul quale riflettere in fase di progettazione.
Penso che noi progettisti non dobbiamo dimenticare di avere una forte responsabilità etica e sociale per quello che facciamo, per due ragioni: la prima è che ciò che costruiamo lascerà traccia per molto tempo e caratterizzerà, nel bene o nel male, i luoghi in cui andiamo ad operare per moltissimi anni; la seconda perchè, concluso il nostro lavoro, la nostra architettura diventerà di chi la vivrà, di chi vi lavorerà, di chi vi trascorrerà il suo tempo.
Solo la bontà e la qualità di un progetto possono renderlo sostenibile nel tempo e consentirgli magari di superare la funzione specifica a cui la costruzione è stata destinata, come ad esempio è successo per molti palazzi storici, oggi convertiti in musei o scuole, gallerie, sedi diplomatiche, etc.
Penso sia arrivato il tempo di affrontare con più attenzione ed impegno progettuale il dibattito sulla differenza tra “costruzione umida” e “costruizione a secco”, anche in riferimento alla sempre più incalzante esigenza di sostenibilità con cui la progettazione deve confrontarsi.
E’ una questione molto delicata, soprattutto nel nostro paese che vanta una tradizione del costruito fondata sui principi della costruzione “umida”.
Mentre nel sistema cosiddetto “umido”, il cantiere è il luogo in cui i materiali grezzi si lavorano e le parti dell’edificio si costruiscono, partendo da materie prime ed elementi da legare tra loro con l’ausilio di malte ed intonaci, quello a secco fa riferimento ad un modello basato sul design di un sistema di elementi da produrre in fabbrica ed assemblare in loco, ed è caratterizzato da un processo progettuale più vicino alla logica dell’industrial e del product design. Esemplare in questo senso è il lavoro di Jean Prouvè.
E’ consuetudine associare la costruzione a secco all’edilizia industriale che esprime forme quasi prive di valori estetici.
Questo è vero solo in parte e riguarda l’edilizia industriale che è stata costruita a partire dagli anni ’70, quando è venuto meno il ruolo del progetto e si è affermata la strategia della standardizzazione e della vendita di moduli a catalogo. Escludendo il magistrale lavoro di Mangiarotti sulla prefabbricazione, le zone industriali sono diventate aree di grandi cassoni “vuoti di progetto”, e questo non sempre è legato a problemi di budget.
E’ importante riconsiderare il progetto come pratica essenziale della costruzione, anche per gli insediamenti industriali; se vediamo infatti molti degli edifici produttivi degli anni ’50, ci rendiamo conto di trovarci davanti ad architetture di grande impatto, che se dismessi diventano luoghi in cui tutti noi vorremmo vivere: i cosiddetti loft.
Il progetto non ancora fatto da Gabriele Buratti.
Mi piacerebbe occuparmi di un contenitore pubblico, una scuola, un museo, o qualcosa del genere, per sperimentare il concetto di domesticità in un luogo dove un numero elevato di persone condivideranno gli stessi spazi per la maggior parte della loro giornata. La speranza è quella di vedere, a distanza di anni, un tuo progetto vissuto bene e apprezzato dalle persone che lo frequentano quotidianamente.
Redazione Tracce
Articolo a cura di Giuseppe Allegro
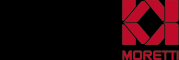




![Ospedale S. Luca, Milano “La costruzione del nuovo Ospedale S. Luca di Milano ci […]](https://tracce.morettispa.it/wp-content/uploads/2013/03/Ospedale-S.Luca-115-100x115.jpg)
![Nox Hotel, Ljubljana, Slovenia Il Nox Hotel, progetto di architettura di Niki Motoh – […]](https://tracce.morettispa.it/wp-content/uploads/2013/12/Nox-Hotel-Ljubljana-cover-100x110.jpg)
![Edilizia abitativa: percorso più semplice per il FIA Dal 2013 cambia il parametro limite di partecipazione per il […]](https://tracce.morettispa.it/wp-content/uploads/2013/12/FIA-cover-100x110.jpg)
![Rafiq Azam Architecture for Green Living Rafiq Azam Architecture for Green Living è la prima monografia […]](https://tracce.morettispa.it/wp-content/uploads/2013/11/RAFIQ-AZAM-cover-100x120.jpg)