Good Moorning,
Mr. Richard Meier

L’architetto newyorchese ha concesso in esclusiva a Tracce un’intervista libera dai canoni classici del personaggio famoso, una conversazione aperta al dialogo professionale e disponibile a rivelarci non solo i suoi progetti, ma anche i lati più umani di una carriera straordinaria.
“In questi ultimi anni mi sono trovato – ci dice Meier – a riflettere sempre più spesso sul senso del mio lavoro e dell’architettura contemporanea. Mi sono accorto di come la lezione di maestri come Le Corbusier o Breuer, contengono ancora moltissimi spunti per sperimentare nuovi percorsi, ma soprattutto per considerare quello che stiamo facendo oggi. Lo scenario della civiltà contemporanea è certamente dominato dal concetto di velocità, di immaterialità, in tutti i campi. Eppure proprio l’architettura, con i suoi ritmi necessariamente più lenti rispetto a quelli di altre arti visive, con il suo essere necessariamente materia concreta, ci offre l’opportunità di una maggiore e più analitica riflessione. A volte ci si dimentica che alla base dell’architettura è, e resta, la percezione visiva. L’architettura è parte integrante delle arti visive. Questo però non significa che dobbiamo privilegiare solo la parte scenografica, perché nell’opera architettonica, a differenza che in un quadro, si vive, la si può considerare anche dall’interno, si entra in relazione diretta con essa. Per questo ho sempre dedicato molto impegno sia al tema della percezione, sia a quello della vivibilità degli spazi che vado a progettare. Per quanto riguarda la percezione pongo logicamente molta attenzione alla luce. La percezione significa essenzialmente saper gestire e guidare la luce, prima di tutto utilizzare la luce naturale nelle sue qualità. Nello stesso tempo cerco sempre di non dimenticare che l’architettura va al di là dell’impressione visiva, per quanto importante. Nel progettare comincio quindi sempre dalla riflessione sulla funzione alla quale sarà destinata l’opera. In questo modo di procedere, ma ancora più di considerare la mia attività, sono stato aiutato molto dalla formazione che ho ricevuto, sia a livello universitario, sia negli importanti studi di architettura dove ho cominciato la mia carriera. E’ stato un approccio fortunato, molto liberale, che mi ha fatto da subito considerare l’archittetura come parte integrante delle arti in generale e allo stesso tempo con valenze autonome. Alla Cornell University, in particolare, vi era la possibilità di imparare liberi dalle influenze dominanti. Dopo la laurea ho viaggiato molto, soprattutto in Europa, e ho avuto l’occasione di incontrare architetti straordinari, dai quali ho attinto moltissimo. Poi però ho avuto anche la forza di crearmi una personalità autonoma: credo che questo sia fondamentale nella carriera di un architetto, come di qualsiasi altro artista: riconoscere la grandezza dei maestri ma saperli anche metterli in discussione. Il passato è indispensabile, ma bisogna guardare al futuro. Ritengo che questo modello di riflettere e agire si noti molto bene, ad esempio, nel Getty Center for Art and Humanities, realizzazione alla quale sono molto affezionato. Una vera e propria città della cultura, che accoglie edifici museali e di ristorazione, una corte-agorà, un auditorium, cortili, giardini. Vi si trova la lezione del passato, perfino apertamente neoclassica, ma anche un’energia innovativa forte, prorompente. Questa mia concezione dell’architettura mi ha seguito sempre anche a livello di possibilità di progettare. Quando ho ricevuto il Pritzker Prize ho capito che avevo individuato un percorso che mi avrebbe offerto la possibilità di realizzare molte delle mie ambizioni. Ad esempio mi ritengo fortunato di aver potuto lavorare così a lungo e a così alto livello sul tema del museo, del contenitore attivo al servizio dell’arte. L’Atheneum a New Armony, il museo d’arte di Atlanta, il museo di arte decorativa a Francoforte, la sistemazione urbana con sala assembleare e spazio espositivo a Ulm, il museo di arte contemporanea a Barcellona, di etologia ancora a Francoforte e il Jean Arp a Rolandswerth. In ognuno di questi miei progetti sono convinto che spicchi la passione, oltre alla professionalità, nel progettare spazi per accogliere opere d’arte. C’è tutto il fascino del lavoro dell’architetto quando si pensa e si opera al servizio di un museo. E’ l’attività che forse meglio di altre unisce progettazione e filosofia. Il nostro compito non è infatti tanto quello di dare una raffigurazione del mondo, ma di strutturare un insieme di relazioni tra segni e comunicazioni, che assumono valore proprio dalle reciproche relazioni. Gli spazi museali evidenziano inoltre come l’architettura è un continuum: ogni generazione informa quelle seguenti. Quello che io faccio è diverso da quello che è stato fatto nei periodi precedenti, ma c’è sempre una relazione che ci riporta alla dimensione umana. Tutto questo nasce anche dal grande rispetto che nutro per l’ambiente nel quale si collocano gli edifici che progetto. Penso di averlo dimostrato recentemente anche con il museo che accoglie l’Ara Pacis a Roma. E’ l’opera antica che guida la progettazione moderna, allo stesso tempo non voglio esserne succube. Voglio comunque sperimentare, anche se so che mi trovo di fronte ad una delle più importanti opere d’arte dell’intera civiltà romana, e non solo. Cerco quindi di stabilire una relazione, che non è stilistica, ma filosofica, intellettuale, umanistica, oltre che umana. Non solo proteggo e conservo, ma creo, ho la voglia e la possibilità di comunicare prima di tutto con l’Ara Pacis stessa. Aiuto il visitatore a comprendere, svelo e rivelo. Non dimentico inoltre che mi trovo in una città contemporanea, con tutte le sue esigenze e problemi, dall’afflusso turistico alla viabilità. Il museo per l’Ara Pacis è stato uno straordinario esempio di quello che può fare e può essere oggi l’architettura: il ponte fra il passato, presente e futuro”.
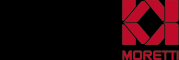
![Ospedale S. Luca, Milano “La costruzione del nuovo Ospedale S. Luca di Milano ci […]](https://tracce.morettispa.it/wp-content/uploads/2013/03/Ospedale-S.Luca-115-100x115.jpg)
![Nox Hotel, Ljubljana, Slovenia Il Nox Hotel, progetto di architettura di Niki Motoh – […]](https://tracce.morettispa.it/wp-content/uploads/2013/12/Nox-Hotel-Ljubljana-cover-100x110.jpg)
![Edilizia abitativa: percorso più semplice per il FIA Dal 2013 cambia il parametro limite di partecipazione per il […]](https://tracce.morettispa.it/wp-content/uploads/2013/12/FIA-cover-100x110.jpg)
![Rafiq Azam Architecture for Green Living Rafiq Azam Architecture for Green Living è la prima monografia […]](https://tracce.morettispa.it/wp-content/uploads/2013/11/RAFIQ-AZAM-cover-100x120.jpg)